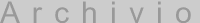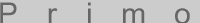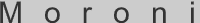LA RIVOLUZIONE DELL'INSEGNAMENTO
Nel corso della sua visita la delegazione ha avuto occasione di visitare principalmente tre scuole di grado diverso.
La scuola elementare della Chen Xian Yie di Nanchino, la scuola media Yenan di Tientsin e il Politecnico Ching Hua di Pechino.
Informazioni sulla rivoluzione dell'insegnamento sono state inoltre raccolte in varie occasioni: visite di fabbrica, Comune popolare o quartiere, per quanto riguarda le scuole gestite da queste unità, e visita ad un ospedale per quanto riguarda la clinica universitaria annessa. I resoconti di tutte queste visite si trovano raccolti in questo stesso numero della rivista.
Trascureremo in questa nota le informazioni raccolte sulle scuole materne e nidi, che presentano problemi di natura alquanto diversa. Esamineremo tre questioni fondamentali: la direzione della scuola, gli insegnanti, il contenuto dell'insegnamento. L'ordine delle questioni non è arbitrario, e corrisponde all'ordine con cui i problemi sono stati affrontati nel corso della Rivoluzione Culturale. Il Presidente Mao infatti dice: "Il problema della riforma dell'insegnamento, essenzialmente è un problema di insegnanti". Il che significa che per realizzare le finalità della rivoluzione dell'insegnamento (momento conclusivo), secondo lo spirito della nota direttiva del 7 maggio (1966), è necessario rivoluzionare la visione del mondo degli insegnanti (momento centrale). Ma poiché questa rivoluzione è un momento di lotta di classe, cioè di lotta per il potere, la premessa di ogni rivoluzione dell'insegnamento è l'affermazione ed il consolidamento della direzione della classe operaia sulla scuola: "Per compiere la rivoluzione proletaria nell'insegnamento, bisogna che la classe operaia ne assuma la direzione" (Mao Tsetung). Ed è questo il primo momento.
Il punto di partenza immediato nella rivoluzione dell'insegnamento è stata la ribellione degli studenti di origine proletaria contro il dominio degli intellettuali borghesi nelle scuole.
Il fatto che il nucleo fondamentale degli studenti ribelli sia stato quello degli studenti di origine proletaria non significa che essi siano stati i soli a promuovere e condurre la lotta. Con l'occasione teniamo presente che i compagni cinesi hanno ripetutamente messo in guardia contro l'uso esclusivo del criterio "origine di classe", per giudicare del carattere rivoluzionario di un compagno, sottolineando di contro la necessità di tenere in debito conto il criterio del "comportamento politico".
La ribellione si attua contro la linea della "accumulazione nozionistica al posto di comando" ed a favore di una linea che prenda esempio dall'Istituto politico militare di Yenan (diretto dal Presidente Mao e dal Vicepresidente Lin Piao durante la guerra antigiapponese), nel quale il processo di formazione culturale, politica e militare si identificano fra di loro da una parte, e con la pratica della produzione e della guerra dell'altra. Sembra del tutto verosimile che gli studenti di origine proletaria sentissero più facilmente la estraneità alla loro posizione di classe di una "cultura nozionistica" borghese, risentissero di conseguenza maggiori difficoltà ad adeguarvisi e fossero oggetto di pesanti discriminazioni. Da ciò lo stimolo a riflettere sulla validità della linea di insegnamento. Da ciò la ribellione contro gli "esami imboscate, pieni di domande insolite e bizzarre", da ciò lo scandalo contro la "tensione quotidiana" cui gli studenti sono sottoposti, per progredire negli studi, da ciò il valore esemplare del caso, citatoci all'Università di Pechino della studentessa di origine proletaria, ricattata nell'amor proprio e spinta a volere il massimo dei voti in ogni materia, suicida per non esserci riuscita. Questa tensione nelle scuole era di vecchia data e deve essere interpretata solo come uno dei momenti della tnsione, esistente nella società nel suo complesso dal trionfo della Rivoluzione Socialista alla Rivoluzione Culturale, fra le due linee, quella dello sviluppo verso il comunismo e quella della restaurazione del capitalismo.
Quando nel giugno 1966 un dazibao dell'Università di Pechino fu trasmesso per radio, la tensione latente scoppiò in modo generalizzato in tutte le scuole. Un mese dopo Mao Tsetung scriveva la lettera alle guardie rosse della scuola media annessa all'Università, un altro mese dopo si attuava la grandiosa sfilata delle Guardie Rosse nella Piazza Tien An Men.
Iniziava così il periodo dei viaggi delle guardie rosse in tutta la Cina. Nel gennaio 1967, scoppiava la tensione nelle fabbriche, che andava ben oltre la sollecitazione diretta, da parte degli studenti, e come risultato della lotta che in modo meno palese era già in corso da tempo nelle fabbriche stesse.
La questione della direzione delle scuole
Dall'agosto 1966, da quando cioè i gruppi di lavoro mandati da Liù Sciao Ci all'Università vengono cacciati via, praticamente l'Università Ching Hua di Pechino rimane senza direzione (i corsi sono naturalmente sospesi), occupata dagli studenti, divisi in diverse fazioni che si combattono anche facendo ricorso alla violenza. La questione fondamentale che li divide è appunto quella del modo di ricostituire gli organi dirigenti della scuola, ed in particolare del modo di trattare i vecchi quadri.
Una situazione del tutto analoga si verifica nello stesso periodo alla scuola media Yenan di Tientsin, dove lo scoppio della ribellione studentesca era avvenuto nel maggio 1966 ed aveva dato luogo alla formazione di ben 48 gruppi diversi di studenti ed insegnanti, tutti contrapposti l'uno all'altro. I compagni cinesi ci hanno detto ripetutamente che gli studenti da soli si dimostrarono del tutto incapaci di risolvere il problema della direzione della scuola. Ciò perché impregnati di spirito piccolo borghese, che si manifestava come spirito di fazione, di rivalità personale fra i leaders dei diversi gruppi, di incapacità di misurarsi con il problema generale degli interessi politici del proletariato e con il criterio della sostanziale unità degli interessi della classe lavoratrice. Tutti i gruppi che si contrastano si richiamano a Mao Tsetung, l'uno si vuole più rivoluzionario dell'altro, fioriscono le tendenze "ultrasinistre" ("studiare non serve a niente"). La divisione consente agli avversari di classe di infiltrarsi e di mascherarsi. Dal 23 aprile 1967 all'Università incominceranno gli scontri violenti fra i gruppi contrapposti. Gli occupanti si riducono da 20.000 a 200 irriducibili. Questa situazione all'Università si trascinerà a lungo, fino al luglio 1968, quando vi entrerà la squadra operaia di propaganda del pensiero di Mao Tsetung inviata da 60 fabbriche della capitale, su iniziativa di una tipografia.
Nella scuola media di Tientsin la crisi ha una evoluzione molto più rapida ed anzi questa scuola rappresenta uno dei primi casi di corretta soluzione delle contraddizioni del movimento rivoluzionario. Il 21 gennaio 1967 entra nella scuola la squadra di propaganda del pensiero di Mao Tsetung inviata dall'Esercito Popolare di Liberazione la quale si impegna nella diffusione dei "tre articoli più letti", dell'"Analisi delle classi in Cina", del "Come correggere le idee sbagliate nel Partito" e nella lotta all'egoismo e al revisionismo, proponendosi di addivenire ad una unificazione dei gruppi sulla linea corretta. Il problema fondamentale, per ricomporre l'unità su una linea giusta, essendo quello di imparare a riconoscere chi sono i nostri amici e chi sono i nostri nemici.
L'E.P.L. rappresenta in questo caso, come in molti altri casi nel corso della Rivoluzione Culturale, non unaforza armata repressiva, come è stato detto stupidamente da molti giornalisti borghesi, ma un'avanguardia proletaria dotata di grande prestigio politico che nel corso degli anni precedenti aveva condotto al suo interno un profondo dibattito che ne aveva fatto un fedele interprete del pensiero di Mao Tsetung. Come vedremo subito, in seguito allo sviluppo della Rivoluzione Culturale, al consolidamento del potere proletario nelle fabbriche, nelle scuole entreranno le squadre operaie che ne assicureranno le forme definitive di direzione in collaborazione con l'E.P.L.
L'entrata della squadra dell'E.P.L. provoca una rapida evoluzione della crisi. Il 16 febbraio 1967 una seconda media propone la dissoluzione delle numerose frazioni e la costituzione di comitati di grande alleanza rivoluzionaria unitari sulla base delle classi (in ogni classe). La squadra dell'E.P.L. appoggia la proposta ed i comitati si costituiscono entro il 28 febbraio 1967. Dell'esperienza fatta viene fatta relazione al Comitato Centrale e con una sua lettera agli studenti della scuola, del 7 marzo 1967, il Presidente Mao approva la soluzione adattata e la indica ad esempio. (La lettera, nota come direttiva del 7 marzo, verrà pubblicata sul Quotidiano del Popolo un anno esatto dopo, il 7 marzo 1968) Il 1 aprile 1967 viene fondato il Comitato Rivoluzionario della scuola, che rimaneggiato ben 5 volte in tre anni, attualmente risulta composto da: 2 operai, 1 soldato, 5 insegnanti, 5 studenti e 4 quadri rivoluzionari della scuola. La squadra operaia di propaganda interverrà il 2 settembre 1968, inviata dalla fabbrica di cavi elettrici della città.
Come abbiamo già visto la situazione di carenza di potere nell'Università sarà molto più lunga e si concluderà con la formazione della Grande Alleanza rivoluzionaria solo il 16 agosto 1968 a seguito dell'ingresso della squadra operaia (il 27 luglio 1968).
I compagni cinesi hanno sottolineato che, come insegna l'esperienza storica, non ci si può fondare sugli intellettuali, nel processo rivoluzionario, ma è necessario fondarsi sulla classe lavoratrice. Quello che importa sottolineare è che mentre nell'Esercito e nelle fabbriche, come nelle campagne, la crisi politica all'interno del movimento rivoluzionario, le divisioni dei gruppi, la polemica all'interno del partito, sono state superate agevolmente in base al principio secondo cui all'interno della classe lavoratrice non esistono contraddizioni di fondo; all'interno della scuola e fra gli studenti le contraddizioni non sarebbero state superabili senza la direzione della classe operaia, poiché gli studenti da soli, non sarebbero stati in grado di applicare correttamente e fino in fondo la distinzione tra "amici e nemici", lasciandosi andare ad identificare come momenti di contraddizione antagonistica quelli che correvano fra le varie fazioni ed i vari leaders. Il ruolo dell'E.P.L. in questo senso è stato semplicemente quello di un'avanguardia cosciente del proletariato, pronta ad assumersi il compito di realizzare l'unità sulla linea politica corretta.
La soluzione generale perciò del problema della direzione politica è stato risolto attraverso lo strumento dei Comitati Rivoluzionari di scuola, composti da operai, soldati, insegnanti, studenti e quadri.
Non dappertutto la componente E.P.L. è peraltro reperibile: per esempio nella scuola elementare di Nanchino non era presente come evidentemente non era presente la componente studentesca.
Ma il problema della direzione ha dei risvolti più complessi che non quelli che noi chiameremmo genericamente i problemi della direzione "politica". Secondo una terminologia abituale per noi, per "direzione politica" si intenderebbe semplicemente il controllo dei contenuti strettamente "politici" dell'insegnamento ecc. Come ci è stato detto vi erano anche degli insegnanti sinceri comunisti, d'accordo con la "direzione politica" della classe operaia, ma che rivendicavano comunque la direzione scientific e didattica agli esperti, cioè a se stessi. Ma è appunto su questo terreno che la tradizione culturale borghese veniva messa in discussione dalla Rivoluzione Culturale. Veniva cioè posta in discussione l'ipotesi stessa che esistesse un ceto sociale " depositario della scienza" che tramandava di generazione in generazione metodi e segreti. Quello appunto che veniva contestato radicalmente era il carattere mascheratamente classista di una tale concezione del "sapere" e la sua sostanziale scorrettezza dal punto di vista della dottrina della conoscenza propria della ideologia del proletariato: il marxismo leninismo-pensiero di Mao Tsetung. Se è vero che la conoscenza razionale deriva dalla pratica, se è vero che la pratica è pratica della produzione e della lotta di classe, dal punto di vista sociale solo la classe operaia può essere portatrice di un'autentica esperienza scientifica. Gli "esperti" e gli "scienziati" appaiono solo come dei collezionisti di nozioni, degli alambiccatori di nozioni, la cui utilità loro sfugge, la cui misteriosità è tale solo nei confronti del proletariato (cui si vuole nasconderle), mentre è piena disponibilità per la classe dirigente borghese, sia essa di nuovo o vecchio tipo. Gli "scienziati" staccati dall'esperienza della produzione e della lotta di classe non sono neppure i depositari del metodo scientifico, che nelle loro mani diviene solo un ricettario idealistico, mentre solo nelle mani della classe operaia, può consistere nel materialismo-dialettico.
Ed ecco perciò in che senso solo gli operai, emancipati ideologicamente dalla ideologia borghese, padroni della ideologia propria della loro classe (il marxismo-leninismo-pensiero di Mao Tsetung), "informati" dai vecchi esperti e scienziati del bagaglio nozionistico che questi ultimi posseggono, e di cui solo una parte è realmente utile (cioè scientifica, parte che la classe operaia è perfettamente idonea a riconoscere), mentre un'altra (una buona metà, dice Mao Tsetung) è solo fumo negli occhi, possono effettivamente da ora in avanti dirigere effettivamente ed attuare personalmente le attività di ricerca e di studio, dando vita ad un processo al cui termine sta la abolizione del "ceto sacro" degli intellettuali separati dalla classe. Si tratta in tal senso di quella completa laicizzazione della cultura, che solo il materialismo dialettico, come ideologia di classe, può realizzare. Non solo perciò la direzione politica, ma anche la direzione didattica e scientifica della scuola deve essere affidata alla classe operaia. Così in tutte e tre le scuole da noi visitate, gerarchicamente subordinate alla direzione politica del Comitato Rivoluzionario, funzionano le nuove "direzioni didattiche", formate da comitati misti di operai e personale della scuola (studenti compresi). Il problema chiave è il problema politico: quando si ha il potere politico si ha tutto, quando si perde il potere politico non si ha niente. E, come dice il Vice Presidente Lin Piao: "il potere politico è il gruppo dirigente". Quella sopra descritta è stata la via per la quale questo problema è stato impostato e risolto nelle scuole da noi visitate. Naturalmente residuano gravi problemi, che sono in corso di risoluzione, come quelli relativi alla ricostituzione degli organi del Partito, rimasti sospesi nelle loro funzioni durante la Rivoluzione Culturale e come quelli relativi ai rapporti di dipendenza gerarchica degli organismi dirigenti (i Comitati Rivoluzionari) delle scuole, dai Comitati Rivoluzionari superiori (dell'unità produttiva o dell'unità territoriale prossime).
In sede di discussione del problema della formazione dei nuovi organi di direzione proletaria abbiamo visto discutere un problema che si ripresenterà a vari livelli ed in varie sedi (compresa qulla degli insegnanti): questo è il problema del come trattare i vecchi quadri. Fra le tendenze "ultrasinistre" emerse nel corso della Rivoluzione Culturale vi era stata anche quella che voleva l'allontanamento da posizioni di responsabilità di tutti i vecchi quadri, presi più o meno in blocco. I compagni cinesi dell'Università di Pechino (in modo particolare) hanno lungamente insistito sul carattere erroneo di questa tendenza e sulla sua pericolosità, poiché forniva (come la tendenza opportunista di destra) serie possibilità agli elementi reazionari di mascherarsi. La ragione di ciò è che il problema vero non era quello di sostituire alcune persone con altre persone, scegliendo le nuove sulla base di declamazioni rivoluzionarie, ma di mutare il ruolo stesso dell'"organo dirigente", di trasformare profondamente lo stesso significato della funzione del dirigente, formando nella lotta le coscienze delle masse e dei quadri insieme. Si trattava di distruggere per sempre la concezione borghese del quadro dirigente, come membro di una casta privilegiata, "proprietario privato" del potere nella società, per affermare il ruolo del quadro come avanguardia cosciente della classe, elemento legato profondamente alle masse, momento attivo della dialettica basso-alto-basso, che armato del pensiero di Mao Tsetung è in grado di orientare il processo di espressione e creazione da parte delle masse, ed in particolare di quelle operaie, della loro funzione dirigente.
Di fronte a questo compito il presidente Mao sottolineò ("La grande maggioranza degli intellettuali del nostro paese vuole progredire ed è disposta ad essere rieducata" "Gli intellettuali ostili rappresentano nel nostro paese un'infima minoranza") che la stragrande maggioranza dei quadri era nella stessa situazione; né buona né cattiva; pochi i cattivi, non moltissimi gli elementi trainanti e di punta (che invece nascevano nel corso della lotta come nuovi elementi fra le masse), quasi tutti recuperabili, attraverso la grande critica rivoluzionaria, alla giusta linea.
E' in questo modo che diventava impossibile agli elementi cattivi mascherarsi con una fraseologia ultrarivoluzionaria, e così ottenere di restare in sella nella stessa posizione di privilegio e di appropriazione del potere nella società, che corrispondeva sia alla visione del mondo dei quadri corrotti dal revisionismo che al ruolo obiettivo che l'"organo dirigente" tendeva ad assumere, sotto la spinta degli interessi di classe antiproletari. Tutto ciò dà ragione del fatto che moltissimi dei vecchi quadri, rieducati nel corso della Rivoluzione Culturale, sono presenti insieme alle nuove avanguardie nei Comitati Rivoluzionari. (La testimonianza del primo Vicesegretario del Comitato di Partito della Università, che si può leggere su questo stesso numero di Vento dell'Est, fornisce una idea precisa di quale processo sia stato quello di rieducazione dei quadri.)
La profonda trasformazione, nelle persone e nel ruolo, della direzione delle scuole è così quel primo passo che consente di affrontare le questioni successive: quella degli insegnanti e quella dell'insegnamento.
La questione degli insegnanti
Gli insegnanti sono il momento centrale della trasformazione della scuola. Essi sono il tramite attraverso cui la classe dirigente trasmette i suoi valori alle nuove generazioni, attraverso cui si propongono i modelli sociali. Essi stessi sono un ceto che svolge un ruolo dirigente nella società, essi stessi quasi automaticamente propongono se stessi e la loro condizione sociale, come modello ai giovani.
Alla scuola elementare di Nanchino ci è stato illustrato un esempio tipico di atteggiamento ed evoluzione della concezione del mondo di una insegnante (vedi testimonianza pubblicata in questo numero della rivista). Si tratta di quella insegnante che considerava il proprio lavoro un el lavoro, perché era un lavoro pulito, e che ovviamente proponeva di conseguenza ai giovani come modello sociale quello del funzionario, che, anche esso fa un lavoro pulito. Nella logica della proposizione di questo modello sociale è evidentemente compresa la concezione della scuola come iter di iniziazione dei giovani fra i quali "i migliori", verranno selezionati per fare un lavoro pulito, un lavoro che nella società fanno in pochi, mentre le grandi masse, fanno un lavoro che sporca le mani ed i vestiti.
Che cosa deve intendersi per "lavoro pulito"? Evidentemente un lavoro distaccato dagli strumenti della produzione, un lavoro tranquillo, lontano dalle grossolane tensioni quotidiane della lotta di classe. In che cosa può consistere questo "lavoro pulito"? Evidentemente nel rimasticamento di una mole di nozioni e di un flusso di informazioni, operato al proprio tavolino, e rinviato al basso, dove si produce e si lotta, livello a cui l'opinione del funzionario si impone come "direttiva" dotata di naturale autorità. La funzione di elaboratore di nozioni e di informazioni così perpetua se stessa, anche attraverso la scuola dove seleziona i nuovi "chierici", dove identifica come "migliori" i giovani che, non solo e semplicemente sono più capaci intellettualmente di svolgere questo lavoro, ma che sono particolarmente capaci a causa del fatto, di fondamentale importanza, che in questo lavoro credono come in un valore.
Ma nella scuola vi sono i figli degli operai, anzi essi sono la maggioranza, che dalla esperienza dei genitori imparano a diffidare di questi funzionari che danno ordini. Nel paese circolano a livello generale le direttive rivoluzionarie del Presidente Mao, e la contraddizione scoppia anche all'interno della piccola scuola elementare di Nanchino. L'insegnante "perde la faccia", cioè vede discusso e contestato il fondamento stesso del suo prestigio, deve riconoscere l'errore in cui è incorsa.
La prima reazione è "nichilista", "estremista di sinistra": allora insegnare non serve a niente, oppure è difficilissimo insegnare, contemporaneamente svolgendo un ruolo che nega se stesso. Tanto vale lasciare l'insegnamento, entrare nella produzione.
In un certo senso a questa esigenza emotivamente giustificabile si viene incontro, perché l'insegnante è mandata ad arricchire le sue esperienze in mezzo ai lavoratori in una Comune Popolare, (perché questo vuol dire "rieducazione"). Qui sperimenta ed apprende qualche cosa che né la precedente esperienza privilegiata, né la critica subita nella scuola avevano potuto insegnarle: la generosità, lo spirito di sacrificio, l'altruismo che caratterizzano la concezione della vita dei proletari e dei contadini poveri. Il loro impegno collettivo a mettere al servizio dei fratelli di classe l'energia e le capacità di ciascuno, quali che siano e senza risparmio. Per cui non esistono lavori "troppo difficili". Apprende anche a vedere come un tutt'uno lo spirito di altruismo, la collettivizzazione degli sforzi, il saldo mantenimento del potere nelle mani dei proletari e la garanzia di benessere materiale per il popolo. E' così indotta ad accettare nuovamente il suo "difficile" ruolo di insegnante, profondamente rinnovato nel significato e nel contenuto. Questo tipo di esperienza, questo "iter della rieducazione", è stato quello seguito dalla grande maggioranza degli insegnanti, di modo che oggi nella grande maggioranza sono stati recuperati. Per fare un esempio numerico nella scuola media Yenan su 72 insegnanti della vecchia scuola, 66 erano già reintegrati nelle loro funzioni al momento della nostra visita. La trasformazione perciò del corpo insegnante ha voluto essenzialmente dire armare dell'ideologia proletaria i docenti, farne dei servitori del popolo, porre al primo posto la politica e nel caso di specie la politica di formazione in mezzo al popolo dei successori della causa proletaria. La eliminazione dei modelli educativi borghesi e revisionisti, la eliminazione del ruolo privilegiato dell'insenante apre anche la possibilità di introdurre sangue nuovo nel corpo insegnante stesso. Gli operai delle squadre di propaganda oltre a guidare il lavoro delle officine della scuola, svolgono attiva opera di insegnamento nelle classi in particolar modo per quanto riguarda le materie politiche. Ma non solo. Nella scuola media Yenan, al momento della nostra visita, nel corpo insegnante erano stati incorporati sei nuovi insegnanti, operai e contadini poveri ed inoltre, in tre anni, si erano avvicendati un centinaio di contadini, operai o soldati a tenere brevi corsi. Questi nuovi insegnanti facevano parte integrante degli organi della "direzione didattica" della scuola. Anche i mutamenti intervenuti nel corpo degli studenti operano nella stessa direzione, quella d'immergere il personale della scuola nel popolo lavoratore e nei suoi problemi. Nella scuola media lo sforzo per estendere a tutti i giovani dai 7 ai 17 anni la frequenza delle scuole elementari e medie evidentemente va a vantaggio della componente proletaria della popolazione scolastica. Mentre alla Università il giovane perverrà insieme ad altri suoi colleghi più anziani, non dalla scuola media, ma dalla fabbrica o dalle campagne dove esservisi già inserito come operaio o contadino ed avervi lavorato almeno 2 o 3 anni, per poi ritornarvi dopo gli studi.
La rivoluzione nell'insegnamento
I compagni cinesi hanno reiteratamente affermato che l'intero problema della trasformazione del piano di studi, è un problema non ancora risolto che parzialmente e che l'attuale è una fase di sperimentazione, nella quale i provvedimenti adottati sono soggetti a continue modificazioni e miglioramenti.
Comunque le linee di tendenza sono ben chiare fin da ora ed il modello a cui la trasformazione si ispira, nelle sue grandi linee risulta tracciato fin da ora con molta chiarezza.
Le questioni fondamentali sono due e si riducono poi a due aspetti della stessa questione: e sono quelle della integrazione del processo di trasmissione delle nozioni e della educazione ai principi del materialismo dialettico (il marxismo-leninismo-pensiero di Mao Tsetung) con la esperienza della produzione e della lotta di classe.
Il modello negativo da cui si prende le mosse, per rifiutarlo, è quello della scuola in cui le nozioni si fanno derivare dalle nozioni, con metodo libresco, e con l'ovvia implicazione che, quella di manipolare le nozioni e le informazioni, è funzione separata dalla produzione e dalla lotta di classe, attribuita ad un ceto separato dal proletariato.
L'obiettivo finale della trasformazione appare non tanto quello di raggiungere un qualunque equilibrio tra insegnamento nozionistico, esperienze pratiche di laboratorio ed "indottrinamento" politico, quanto invece quello di superare radicalmente con un salto qualitativo (e non con modifiche quantitative delle componenti del programma degli studi) la separazione fra la scuola e la fabbrica, separazione che non è che un aspetto della separazione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, separazione che insieme a quella fra fabbrica e campagna è retaggio della società capitalistica, della società cioè dove è imposta la separazione fondamentale: quella fra classe dirigente degli sfruttatori e classe diretta degli sfruttati.
Da ciò il fatto che fin da ora gli studenti dedicano un'importante parte del loro tempo scolastico (circa il 10% alle elementari ed il 30% alle medie) non ad esperienze pratiche di laboratorio, ma al lavoro produttivo in officine della scuola a stretto contatto con le fabbriche (alle quali forniscono il loro prodotto) ed a stretto contatto con gli operai che da queste fabbriche sono venuti a dirigere la scuola. Nell'Università, dove l'età degli allievi lo consente, il lavoro produttivo è svolto oltre che nelle officine dell'Università stessa in aziende agricole, canieri e fabbriche (la Università da noi visitata era un Politecnico), esterne ed anche lontane; aziende in parte appartenenti organicamente all'Università stessa, in parte inserite in unità produttive esterne. Si noti anzi che il modello di scuola universitaria è oggi la facoltà costituita interamente all'interno della Fabbrica di Macchine Utensili n. 1 di Shanghai, nella quale allievi della scuola ed operai della fabbrica sono la medesima cosa.
E l'insegnamento della "politica" anch'esso non è un fatto libresco. Non esiste un corso di "ideologia comunista", ma accanto a veri e propri corsi di storia, improntati al metodo del materialismo storico e della analisi di classe, ogni materia tradizionale (lingua, aritmetica, chimica ecc.) e insegnata facendo risalire le nozioni al loro uso di classe. Ma "politica" in senso stretto è soprattutto la discussione della attualità politica interna ed internazionale, insieme alla discussione delle esperienze dei soldati, contadini ed operai che insegnano nella scuola, fino alla discussione delle esperienze sociali ed intellettuali degli stessi giovani allievi, alla luce del marxismo-leninismo-pernsiero di Mao Tsetung. E come risulta dalle testimonianze pubblicate in questo stesso numero, in definitiva il giudizio scolastico dipende essenzialmente dai progressi dell'allievo nella applicazione in modo vivo del pensiero di Mao Tsetung, più di qualsiasi valutazione sul grado di assimilazione di nozioni di cui l'allievo sia stato capace.
Ciò nonostante, nella attuale fase, non si può certo dire, né i compagni cinesi dicono, che la congiunzione fra scuola e fabbrica sia una dimensione completamente realizzata. Anzi, proprio perché essa non è ancora completamente realizzata, gli effetti "diseducanti" dal punto di vista politico della scuola permangono, e perciò in ogni caso i giovani usciti dalla scuola hanno bisogno di essere "rieducati" alla scuola degli operai e dei contadini poveri. Questo è il senso dell'obbligo fatto a tutti i giovani usciti dalla scuola media di entrare subito nella produzione, ed in generale il senso dell'obbligo fatto a tutti i quadri, per rivoluzionari che siano, di partecipare sempre al lavoro produttivo.
Concludendo possiamo dire che noi abbiamo visitato delle scuole nella Cina socialista, in un momento di profonda trasformazione. Per quanto sia difficile profetizzare le forme che la scuola assumerà in una società comunista, possiamo ben dire di aver visto impostati con chiarezza i problemi fondamentali del potere politico e delle linee di evoluzione della scuola nella direzione della costruzione di una scuola comunista. In tal senso l'esperienza cinese è per noi preziosa, come in generale per il proletariato internazionale.
1970
- Scritti diversi
- Tesina (febbraio 1959)
- La rivoluzione dell'insegnamento (appunti da un viaggio in Cina)
- Lettera dal carcere ai compagni (dicembre 1975)
- La nuova scienza, istituto per il turismo "Claudio Varalli" (1 settembre 1976)
- Soccorso Rosso Militante 1976 - Comunicato stampa del 17 luglio 1976
- Comunicato a seguito dell'accoltellamento nella cella 311 del carcere di San Vittore (gennaio 1976)
- Sui documenti di Palmi, "Forzare l'orizzonte" e l'"Intervista" e sul libro di Curcio e Franceschini "Gocce di sole nella Città degli spettri" (marzo 1983)
- Gioco a dadi: la lotta per il potere secondo il marxismo-leninismo autentico ('84?)
- Lotte nelle carceri, analisi delle fasi (1985)
- Tre casi (giugno 1985)
- Movimento dell'autunno 85 (1986?)
- Il risorgere di posizioni tipo Dunkhem-inquadrato nel discorso sulla ventata reazionaria (1986?)
- Marx scaletta (agosto 1988)
- Marx Bakunin (settembre 1988)
- Strategia internazionale del pentimento (maggio '82)
- Alcune questioni di metodo
- (metodo) (marzo 1992)
- Situazione: appunto da sviluppare sulla dimensione culturale ed istituzionale (aprile '92)
- Situazione: i paesi del ex est: Polonia (aprile 1992)
- Situazione: i paesi del ex est: Russia (aprile/maggio 1992)
- Fondo Sergio Spazzali
- APM