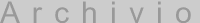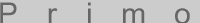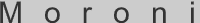marzo 1992
(metodo)
Quale è la situazione in cui ci troviamo (p. es. oggi, in Italia, ma anche in un altro paese, in un'area, nel mondo intero), e quali sono i fattori che operano nel senso della sua trasformazione? Una tale questione, molto "pratica", molto "terra-terra", implica la soluzione di questioni teoriche di primaria importanza e di grande difficoltà. Naturalmente per risolvere questa questione bisogna procedere a quella che si chiama una "analisi concreta della situazione concreta". Ce ne occuperemo in altri contributi. Ora vogliamo solo, più brevemente e chiaramente possibile affrontare le questioni teoriche la cui soluzione corretta è una condizione necessaria anche solo ad una corretta impostazione di questa questione: "quale è la situazione in cui ci troviamo e quali sono i fattori che operano nel senso della sua trasformazione?".
Infatti molti e diversi sono i criteri con i quali una situazione può essere analizzata e così i fattori operanti nel senso della sua trasformazione. Per esempio si possono impiegare il criterio della durata della vita media degli esseri umani, del tasso di natalità e mortalità, delle statistiche sanitarie, dello stato delle risorse naturali e delle sue variazioni, del livello culturale degli esseri umani ecc. ecc. Tutti criteri effettivamente usati in diverse discipline (sociologia, etnologia, antropologia, ecologia, ecc.), che presentano spesso qualche utilità più o meno limitata. Ma, attenzione, vi sono criteri che colgono i caratteri di una situazione più in profondità, colgono cioè in modo più coinvolgente (al limite in modo totalmente coinvolgente, e cioè nel solo modo scientifico) la molteplicità dei fenomeni che costituiscono questi caratteri. Si tratta dei due criteri che più ci interessano, e, fin da un primo approccio, appaiono effettivamente più interessanti, quali del resto sono stati valutati, almeno negli ultimi due secoli, nell'ambito dei più diffusi ed influenti "sistemi culturali".
In primo luogo si tratta del criterio strutturale, principalmente del criterio economico. Secondo tale criterio l'analisi di una situazione è principalmente, da una parte, l'analisi della qualità e quantità di forze produttive in presenza e dei fattori che tendono a trasformarne la qualità e quantità. Da un'altra parte l'analisi dei rapporti di produzione, cioè dei rapporti fra gli uomini nel processo produttivo, e dei fattori che tendono a trasformarli. Si può sostenere, in questo contesto, che tutti gli altri elementi componenti i caratteri di una situazione o si riducono alle forze produttive ed ai rapporti di produzione o sono direttamente o indirettamente modellati da essi.
In secondo luogo si tratta del criterio sovrastrutturale, del criterio politico/culturale. Secondo tale criterio l'analisi di una situazione e dei fattori che tendono a trasformarla è principalmente l'analisi delle idee che dominano e/o si scontrano in un dato momento (p. es. questo) nella società umana ed in particolare delle idee che (nella logica di questo criterio) danno forma e giustificazione ai meccanismi (ed organismi) di decisione sui temi di interesse collettivo (politici nel senso più largo). In genere il criterio strutturale si qualifica per materialistico, il criterio sovrastrutturale per idealistico.
Il criterio materialistico, nel modo in cui l'abbiamo indicato (forze produttive e rapporti di produzione, come elementi base di una situazione, cioè criterio economico), ha molti parenti, più o meno legittimi, che per molti aspetti gli assomigliano come si assomigliano delle gocce d'acqua fra di loro, nonostante le apparenti diversità, anche radicali. Per esempio il criterio del materialismo biologico, per cui l'elemento fondamentale di una situazione è costituito dallo stadio raggiunto dalla evoluzione delle strutture naturali in particolare del sistema nervoso umano (teoria detta nche dell'"uomo neuronale"). Ancora per esempio il criterio del "materialismo psichico", per cui la situazione è determinata dai contrastanti influssi delle passioni, individuali e sociali, latenti e/o inconsce dell'animo umano del singolo e dell'inconscio collettivo. Ancora, per esempio paradossale, il materialismo "teologico" per il quale la situazione ed il suo trasformarsi sono determinati dall'azione divina, dalla provvidenza divina. Altri esempi si potrebbero fare di parenti della stessa famiglia ("la situazione è determinata dalle forme assunte dalla differenza sessuale" ecc.). Tutti questi criteri che abbiamo detto un po' genericamente ed in modo apparentemente paradossale, "materialisti", hanno in comune la individuazione di una materia dinamizzante (forze produttive, sistema nervoso, psiche, dio, ecc.) che non è subordinata ad alcuna intenzionalità estranea, ma governa, per mezzo di leggi di bronzo, ogni carattere ed ogni trasformazione della situazione nel suo complesso, ogni elemento, in definitiva, compreso. Non ci compete in questa sede di analizzare più dettagliatamente e più finemente i caratteri dei componenti di questa famiglia. Interessa però sottolineare che si tratta in genere di un criterio (specialmente nella versione: le forze produttive ed i rapporti di produzione come elementi base della situazione, cioè il criterio economico) che ha dimostrato una efficacia assai superiore a quelli precedentemente indicati (che potremmo genericamente indicare come "sociologici"), per la semplice ragione che ha cercato di individuare un carattere della situazione, in qualche modo riassuntivo di tutti gli altri, per lo più in quanto causa di tutti gli altri consentendo così un enorme progresso nella analisi del passato, presente e futuro di una situazione. Cosa che in generale i criteri frammentari di tipo sociologico, non consentono. Naturalmente si potrebbe discutere della sensatezza e dell'utilità di un'analisi del passato, presente e futuro di una situazione. Ma noi qui non ne discuteremo perché siamo partiti da una questione che dà per acquisita la sensatezza ed utilità di questa analisi. La questione iniziale: "Quale è la situazione in cui ci troviamo e quali sono i fattori che operano nel senso della sua trasformazione?".
Il criterio idealistico può presentare anche esso delle varietà, fra di loro strettamente apparentate, correndo le differenze essenzialmente sulla determinazione del soggetto "detentore"/"elaboratore" delle idee e delle scelte. Sia questo soggetto l'individuo, od un frammento soggettivo, o qualche dimensione collettiva (classe sociale, popolo, nazione, umanità e varie altre dimensioni). Anche il criterio idealistico presenta l'interesse di consentire un'analisi unificante della situazione (sempre e per lo più individuando caratteri "causa" degli altri) e perciò anche una analisi del suo passato, presente e futuro.
Questi due criteri (benché più scientifici di quelli "sociologici") tuttavia ci sembrano radicalmente insufficienti, caratterizzati entrambi da una debolezza logica. Tale debolezza logica consiste in questo, che entrambi i criteri identificano il carattere, elemento fondamentale della situazione, in una "cosa" (anche se definita nel modo più sofisticato possibile, la questione non cambia) e non, come realmente è, in un "rapporto". Quale è la differenza?
Una "cosa" può cambiare fin che si vuole ma per certi aspetti, da questo punto di vista i più importanti, deve ben essere e restare la stessa. Altrimenti (cioè "in altro modo") non sarebbe possibile identificarla, non sarebbe possibile parlare di essa. Così le forze produttive, il sistema nervoso, la psiche, dio, i caratteri della sessualità, ma anche i sistemi culturali e gli organismi politici, sono "cose", sono cioè definiti, per gli aspetti più importanti, per ciò che li rende se stessi, identici a se stessi nonostanti tutti i possibili cambiamenti. Un "rapporto" è, per gli aspetti piùimportanti, un cambiamento, il cambiamento. Esso non è costante, identico a se stesso, se non nel suo essere costantemente mutevole, di essere "la mutevolezza in persona". Questa mutevolezza ha un campo nel quale si muove, delle leggi secondo cui si muove, una direzione verso cui si muove. Astrattamente, cioè in definitiva artificialmente, si possono identificare tanti rapporti diversi, col rischio, per identificarli, di farne delle "cose". Perciò è meglio evitare di esaltare la particolarità di ogni singolo rapporto, ed è invece meglio sottolineare sempre i caratteri "universali" del rapporto in quanto tale, che, contrariamente all'apparenza ed all'opinione, costituiscono l'unica espressione concreta del rapporto.
Diciamo che i caratteri universali, cioè concreti, che consentono di analizzare la situazione (al che in definitiva si riduce il nostro scopo) sono (1) la trasformazione del campo della materia naturale e sociale, secondo le leggi proprie date di questa materia nella sua trasformazione, nella direzione di una sempre maggiore complessità (neghentropia) che garantisca la conservazione, (2) e nello stesso tempo la originaria scelta (in cui libertà e necessità coincidono) che questo processo trasformativo mette in moto e sviluppa, manifestandosi come progetto (mondo delle idee) sempre esposto al rischio dell'errore e del fallimento. Questo rapporto trasformativo spiega come attraverso un processo di astrazione, cioè in sostanza un artificio, si possa isolare la "cosa materia" e la "cosa idea", sotto forma di concetti di materia e di idea, benché non di realtà materiale ed ideale.
In ciò grosso modo consiste il criterio del materialismo dialettico, in contrapposizione da una parte al cosiddetto materialismo volgare e, dall'altra, al cosiddetto idealismo soggettivista. Un importante esempio, fra gli altri, delle conseguenze derivanti dall'adozione del criterio del materialismo dialettico per l'analisi della situazione, si ha in relazione al cosiddetto "problema della conoscenza".
I materialisti volgari più estremisti, a proposito della conoscenza, sostengono che la conoscenza è un puro e semplice riflesso delle cose materiali, la cui immagine viene registrata attraverso dei mezzi materiali (organi del senso, sistema nervoso, essi stessi delle cose), nella mente che è essa stessa una cosa materiale, il cervello. (L'agire degli esseri viventi sarebbe di conseguenza un riflesso automatico degli impulsi conoscitivi. Gli esseri viventi, compresi gli uomini, sarebbero dunque degli automi materiali).
Gli idealisti soggettivi più estremisti sostengono invece che le cosiddette cose materiali sono una delle infinite realtà virtuali (o potenziali) che la mente adotta come immagine della realtà, in quanto più funzionale al perseguimento di un fine liberamente scelto. (L'agire degli esseri viventi sarebbe totalmente libero, salvo che nel non essere libero di non esistere; fino al punto di essere il fondamento dell'immagine di una realtà, priva di esistenza al di fuori di questa immagine, se non come virtualità assoluta, materia assoluta. Gi esseri viventi, compresi gli uomini, sarebbero dunque dei puri spiriti, totalmente incondizionati).
Per il materialismo dialettico, contrariamente a quanto molti pensano, non è vero che si debba mediare un po' di materialismo ed un po' di idealismo, mescolati insieme in modo "dialettico" (parola in questo caso usata nel senso di "pasticciato in un modo qualunque"). Per il materialismo dialettico la conoscenza è qualcosa di completamente diverso di quello che è per il materialismo e l'idealismo.
Per il materiaismo dialettico la conoscenza è quel modo di descrivere (attraverso un certo livello di astrazione, un certo artificio) il rapporto generale, per il quale le determinazioni reali, nel senso di storicamente date, si negano in quanto insufficienti alla conservazione della materia e si rapportano alla materia stessa come virtualità/potenzialità per "cercare la via d'uscita". Non vi è dunque conoscenza "pura" al di fuori di un progettare.
Non vi è altra libertà che quella di "sbagliare cercando la via d'uscita". Le determinazioni raggiungono la loro massima espressione di necessità, negandosi e conoscendo le virtuali alternative. (L'agire degli esseri viventi dunque è qualificato dal campo delle determinazioni reali, storicamente date, fra le quali le determinazioni reali dell'essere vivente stesso, dalle leggi di trasformazione implicite nelle determinazioni storicamente date e nelle alternative virtuali conosciute, dalla scelta della direzione neghentropica, nella quale libertà e necessità vengono a coincidere. La conoscenza delle alternative virtuali può essere descritta come essa stessa una realtà storicamente data e che si dà, il cui evolversi non è conseguenza automatica dei riflessi meccanici delle altre determinazioni materiali della realtà sulla determinazione materiale "cervello", né operazione demiurgica di una spiritualità arbitraria, ma arrischiata approssimazione la cui unica autonomia e libertà sta nel permanente ed inevitabile rischio di sbagliare (nel senso più ampio di sbagliare nell'individuare fini, mezzi, cause, leggi, ecc.), rischio affrontato sia nell'astratto "confronto delle idee con la realtà" che nell'altrettanto astratto "confronto delle idee fra di loro".
Dunque se vorremo applicare il criterio del materialismo dialettico per analizzare la situazione, in quanto è il criterio più idoneo a cogliere la totalità degli aspetti (e dunque il più scientifico) ed è perciò anche il più adatto ad analizzarne il passato, il presente ed il futuro virtuale, dovremo seguire un sistema ben preciso.
In primo luogo bisogna valutare quale considerazione facciano le varie frazioni della borghesia (come costituite ed identificate a livello delle singole nazioni, ma anche a livello internazionale) dello stato attuale delle forze produttive e degli attuali rapporti di produzione, in relazione alla fondamentale necessità per ciascuna frazione di mantenere la sua posizione ed il sistema (quello capitalistico) nel quale questa posizione si colloca.
Naturalmente questa valutazione dovrà essere "critica", nel senso di comprendere un apprezzamento del grado di verosimiglianza delle basi di fatto che vengono assunte dalle diverse considerazioni da parte delle diverse frazioni della borghesia. Questa analisi conclude nel disegno del quadro delle contraddizioni fra le diverse frazioni della borghesia, le contraddizioni interborghesi, per quanto riguarda i progetti di trasformazione/conservazione sia della base materiale (struttura) che delle istituzioni politiche (sovrastruttura).
In secondo luogo bisogna valutare criticamente quale considerazione facciano i diversi popoli oppressi dall'imperialismo (ed in modo segnalato le diverse e contradditorie frazioni in seno a questi popoli) dello stato attuale delle forze produttive, rapporti di produzione e sovrastrutture politiche (il potere politico) in relazione alla primaria necessità di emanciparsi dai vincoli oppressivi dell'imperialismo, che li porta alla disgregazione ed alla distruzione. Questa analisi conclude nel disegno del quadro delle contraddizioni fra imperialismo e popoli oppressi, per quanto riguarda i progetti di trasformazione/conservazione sia della base materiale (struttura) che delle istituzioni politiche (sovrastruttura).
In terzo luogo bisogna valutare criticamente quale considerazione faccia il proletariato - dei singoli paesi e del mondo nel suo insieme, e segnatamente i diversi strati sociali che compongono il proletariato - dello stato attuale delle forze produttive, rapporti di produzione e sovrastrutture politiche (il potere politico) in relazione alla primaria necessità di difendersi dallo sfruttamento capitalistico e procedere sulla via della propria emancipazione. Questa analisi conclude nel disegno del quadro delle contraddizioni di classe, per quanto riguarda i progetti di trasformazione/conservazione sia della base materiale (struttura) che delle istituzioni politiche (sovrastruttura).
Il carattere critico richiesto a queste valutazioni significa che in queste valutazioni compare in modo esplicito un punto di vista dal quale le valutazioni vengono effettuate. Un punto di vista che, a tutti gli effetti, fa esso stesso parte della situazione. Il fatto di aver usato espressioni come "in primo luogo", "in secondo luogo", "in terzo luogo", non indica in alcun modo un ordine di importanza od un ordine di tempo obbligato. In realtà l'esame dei tre ordini di contraddizione deve essere effettuato considerandoli fra di loro intrecciati, in rapporto instabile, che vede nel decorso storico prevalere ora l'uno ora l'altro ordine; prevalenza la cui individuazione è della massima importanza per l'identificazione della situazione attuale, a tutti i suoi livelli ed in tutte le sue dimensioni.
Bisogna fare molta attenzione a non cadere né nel meccanicismo tipico del materialismo volgare, che vorrebbe tutto spiegare in modo fatalistico e deterministico, né nell'idealismo soggettivista che vorrebbe tutto spiegare sulla base di scelte arbitrarie delle varie forme di soggettività. Spiegazioni che, oltre a tutto, non servono a niente, che sono perfettamente inutili, dato che se tutto è fatalisticamente determinato, non vale la pena di cercare dei perché o dei verso dove e basta mettersi a contemplare i fatali risultati di ogni processo, mentre se tutto è frutto di scelte arbitrarie, non vi è alcun perché o percome da ricercare, né nulla vi è che sia possibile prevedere.
11 Marzo 1992
Per forze produttive intendonsi tutte le "cose" materiali ed immateriali, ivi compresa la forza e l'intelligenza umane, atte alla produzione di altre cose "utili".
- Scritti diversi
- Tesina (febbraio 1959)
- La rivoluzione dell'insegnamento (appunti da un viaggio in Cina)
- Lettera dal carcere ai compagni (dicembre 1975)
- La nuova scienza, istituto per il turismo "Claudio Varalli" (1 settembre 1976)
- Soccorso Rosso Militante 1976 - Comunicato stampa del 17 luglio 1976
- Comunicato a seguito dell'accoltellamento nella cella 311 del carcere di San Vittore (gennaio 1976)
- Sui documenti di Palmi, "Forzare l'orizzonte" e l'"Intervista" e sul libro di Curcio e Franceschini "Gocce di sole nella Città degli spettri" (marzo 1983)
- Gioco a dadi: la lotta per il potere secondo il marxismo-leninismo autentico ('84?)
- Lotte nelle carceri, analisi delle fasi (1985)
- Tre casi (giugno 1985)
- Movimento dell'autunno 85 (1986?)
- Il risorgere di posizioni tipo Dunkhem-inquadrato nel discorso sulla ventata reazionaria (1986?)
- Marx scaletta (agosto 1988)
- Marx Bakunin (settembre 1988)
- Strategia internazionale del pentimento (maggio '82)
- Alcune questioni di metodo
- (metodo) (marzo 1992)
- Situazione: appunto da sviluppare sulla dimensione culturale ed istituzionale (aprile '92)
- Situazione: i paesi del ex est: Polonia (aprile 1992)
- Situazione: i paesi del ex est: Russia (aprile/maggio 1992)
- Fondo Sergio Spazzali
- APM