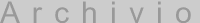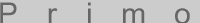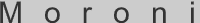Agosto 1988
Il contributo di Marx (scaletta)
Il contributo scientifico di Marx riguarda principalmente le scienze sociali, al livello più alto della definizione teorica del loro metodo.
Possiamo riassumere in tre punti principali il suo contributo.
1) Il c.d. "capovolgimento" nei confronti di Hegel.
Hegel parte dalla constatazione di una società (principalmente la società tedesca della sua giovinezza) lacerata, irrealizzata, nella quale interessi particolari ed interesse generale non trovano composizione. In breve egli formula la tesi di un processo non concluso, ma che tende alla sua conclusione. Ciò che filosoficamente egli esprime come tensione di essenza ed esistenza a conciliarsi, la astrattezza di ogni momento concettuale superandosi nell'unico assoluto; l'idea, lo spirito assoluto. Nella sua maturità egli considererà questo processo concluso nello stato prussiano.
Egli cioè considerò irreale tutto il processo storico, in movimento verso il suo fine, la realizzazione dello spirito assoluto come unica realtà autentica, che attrae a sé tutto il processo storico per il suo compimento. Tutto ciò che è relativo trova spiegazione nell'Assoluto. Marx, a parte la polemica contro la pretesa di identificare lo Stato prussiano come realizzazione dell'Assoluto, prenderà una posizione completamente diversa dal punto di vista teorico.
Egli sosterrà che l'unica realtà è la realtà storica contingente, in perpetua trasformazione per superare le contraddizioni che la percorrono. E che spirito assoluto, idea assoluta sono puri fantasmi. Ed ancora che non esiste alcuna idea assoluta che consenta di individuare un fine verso cui la storia si dirigerebbe.
2) Il c.d. "essere sociale" dell'uomo.
Per Marx l'oggetto della scienza sociale non è l'uomo o la molteplicità degli uomini nelle loro atomistiche relazioni economiche e politiche. L'uomo, gli uomini sono astrazioni se non sono visti nel loro essere espressione delle loro relazioni sociali, le quali sono a loro volta espressione dei rapporti di produzione. Così viene definita la materialità della contraddizione che percorre la società degli uomini e così si identificano nelle collettività definite dai loro ruoli nel rapporto di produzione i soggetti della storia e gli oggetti della conoscenza scientifica.
La cultura borghese è - fin dalle sue più remote origini - andata alla ricerca, dopo il tramonto della religione, della identificazione del procedimento per fondare l'esistenza dell'ente uomo come singolo, entrando in perpetua contraddizione con le forme storiche concrete della società borghese stessa. Il materialismo conseguente di Marx consente di individuare questo procedimento nel concetto di rapporto collettivo dell'uomo con la natura oggetto di trasformazione e nel concetto di contradditorietà storica del modo di organizzazione sociale di questo rapporto. Gli uomini come singoli non sono che astrazioni dei rapporti sociali, prodotti dei rapporti di produzione nei quali sono inseriti e dai quali sono definiti. La cultura borghese, dopo Marx e fino ad oggi, non ha finito di dichiararsi (ovviamente) insoddisfatta dalle soluzioni marxiste ed ha cercato mille altri modi di liberarsi del soggettivismo individualista che la segue dall'origine per ovvie ragioni. Le ragioni di queste polemiche e contraddizioni meritano una più estesa spiegazione.
3) La identificazione nel proletariato della classe sociale che nella società capitalistica può portare in modo rivoluzionario al suo superamento verso la società comunista.
Marx non può essere cercato nella società borghese stessa: se non nel senso che la società borghese, il modo di produzione capitalistico, ha prodotto la forza sociale, la classe dei proletari, che può distruggere la società borghese, risolvendone le tipiche contraddizioni in una società di liberi produttori associati, la società comunista.
Questa identificazione del soggetto rivoluzionario storicamente dato nei tempi moderni, non è stato tratto da Marx da una analisi di astratti concetti filosofici, ma, nel corso della sua esperienza politica, dall'analisi della realtà dei suoi tempi, che, in questo senso, sono ancora i nostri tempi.
Questa analisi ha dimostrato la sua correttezza in oltre un secolo di storia, nel quale il proletariato si è esteso ed ha sviluppato un antagonismo politico enorme contro la società borghese, costituendo ai nostri giorni l'attore di primo piano a livello mondiale delle convulsioni che caratterizzano il capitalismo nella epoca dell'imperialismo, cioè nella sua fase finale. Il fatto che conquiste e rovesci caratterizzano questa forza emergente, di momento in momento, autorizza gli ideologi borghesi a decretarne l'inesistenza, senza tenere conto della lunga onda storica. Cosi in questi ultimi anni ogni sorta di deprofundis è stato recitato sul proletariato mondiale.