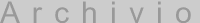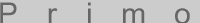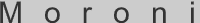Sessione di laurea Febbraio 1959
Ci sono due dialettiche in Marx?
Nella serie di saggi dedicati al problema della dialettica dalla
Rivista di filosofia, numero di aprile del 58, il Prof. Bobbio pubblica
un interessante articolo sul tema della dialettica in Marx.
Nell'articolo vengono affrontati due problemi:
1) se Marx possa essere detto un pensatore dialettico
2) quali siano i significati del termine "dialettica" nel pensiero di Marx.
Alla fine dell'esame della seconda questione il Bobbio giunge alla conclusione che
almeno due sono i significati del termine "dialettica" in Marx.
Data per acquisita la risposta positiva alla prima questione (se Marx
sia un pensatore dialettico) concentreremo la nostra attenzione sulla
seconda ed esamineremo i significati del termine "dialettica" che in
Marx il Prof. Bobbio ci illustra. Innanzitutto precisiamo che non è
esatto considderare la indagine svolta dal Bobbio come limitata al
significato che il "termine" dialettica assume nell'opera marxiana, ma
senz'altro esteso ai molteplici aspetti (duplici nel caso)
dell'applicazione del metodo genericamente definibile come dialettica
(per avere sempre come punto di riferimento una situazione di
opposizioni di contraddizioni, di antitesi, di antinomia di contrasto
che deve essere risolta. (1) nell'opera di Marx; ovviamente ci atterremo
a questo metodo evidentemente di maggiore interesse di una mera indagine
"stilistica".
Il Bobbio svolge una considerazione siffatta: esattamente Engels nella
"Dialettica della natura" individua due aspetti del metodo dialettico
marxiano (2), quello fondato sulla legge della compenetrazione degli
opposti e quello fondato sulla legge della negazione della negazione.
Il primo sarebbe caratteristico dell'analisi statica che Marx fa della
società: analisi diretta ad esaminare i rapporti intercorrenti tra le
strutture sociali esistenti insieme in un determinato momento storico:
tra le classi, tra i sistemi della produzione e della distribuzione,
infine tra struttura e sovra-struttura; analisi che comunque tiene fermi
i termini in contrapposizione, antitesi ecc. Quella che potremmo
chiamare una analisi "sociologica, e secondo la terminologia apologetica
di molta letteratura contemporanea, "obiettiva" e "aperta" (poiché non
obbliga ad adottare nessuna visione prospettica di evoluzione a senso
unico).
L'altro sarebbe caratteristico di Marx filosofo della storia, che
applica la dialettica triadica di Hegel alla sua visione classista, e,
di contraddizione risolta in contraddizione risolta, da eufheben in
aufheben arriva alla società comunista senza classi.
Chi abbia una certa familiarità con gli scritti di Marx non potrà che
confermare la esattezza della considerazione di Bobbio.
Nello stesso saggio che dà origine a questo nostro discorso troviamo
citati gli elementi di riprova più evidenti di questo duplice
orientamento metodologico: da una parte il "Manifesto dei comunisti"
dall'altra il lavoro di analisi economico - politica de "Il Capitale".
Il Bobbio pone alla fine del suo discorso un problema, che poi è il
problema fondamentale in merito alle due dialettiche: "quale dei due
significati di dialettica è storicamente più rilevante, vale a dire dei
due può caratterizzare meglio un indirizzo di pensiero?" (3). Il Bobbio
rimanendo su un piano di formulazioni di una ipotesi di lavoro sceglie
(4) il significato espresso dalla legge della negazione della
negazione.
Il problema è veramente fondamentale, ma forse la sua stessa
impostazione non è abbastanza corretta da riuscire ad evitare una
conclusione forzatamente astratta, come è quella di scegliere un lato
forte da uno debole della dialettica marxiana.
Infatti è sufficientemente "dialettica" la impostazione che il Bobbio
offre del problema stesso del rapporto fra le "due" dialettiche di Marx: rispetta cioè essenzialmente il primo compito del pensatore
"dialettico" di vedere innanzitutto se la opposizione contraddizione,
antitesi, antinomia e contrasto di due termini possa essere risolta,
prima di arrivare alla conclusione che almeno uno dei due aspetti è uno
pseudoconcetto e perciò stesso immediabile e da rifiutarsi ?
In Hegel (Enciclopedia, paragrafi 79/82) la logica è articolata in tre
momenti: a) l'astratto o intellettuale b) il dialettico o
negativo-razionale c) lo speculativo o positivo-razionale. Il che
significa, ai nostri effetti, che dal punto di vista del trattamento
scientifico di ogni realtà finita, l'atteggiamento metodologico può
essere triplice: quello della mente che tiene ferme le determinazioni
finite e le enuncia, senza badare ai loro rapporti, quello della mente
che enuncia le determinazioni nella loro contradditorietà ed in modo che una neghi l'altra (influenza e
compenetrazione degli opposti) ed infine quello della mente che si
sforza di pensare la risultanza della contrapposizione delle
determinazioni e perviene a pensare pertanto il concetto, che come
negazione di certe determinazioni non è il vuoto ed astratto niente, ma
un risultato, appunto (negazione della negazione, pensiero del progresso
storico).
Ora, tutto ben considerato le due dialettiche di Marx non sarebbero per
caso la contrapposizione dei primi due momenti della logicità, momenti
in sostanza prevalentemente statici ed analitici al terzo, il momento
speculativo, essenzialmente dinamico, ed in sede del quale solo è
possibile la scelta etica e politica? Ben giustificata sarebbe la scelta
del Bobbio a favore del momento speculativo, nel senso di attribuire a
questo memento una priorità di tipo appunto logico, poiché come momento
concreto permette lo svolgimento dei momenti astratti. Ma certo non
sarebbe giustificato parlare di un lato più o meno forte della
dialettica, poiché, come d'altronde lo stesso Bobbio afferma, "la
negazione della negazione è per Hegel la categoria generale di
comprensione di tutto il movimento storico, mentre la teoria dell'azione
reciproca non è che (sic!) un capitolo della logica.(5)"
E che fosse lo stesso Marx a pensarla in questo modo ci è confermato da
quanto da lui riportato e scritto nella appendice alla seconda edizione
tedesca del Capitale (6). Egli riporta il seguente giudizio di Maurizio
Block: "una sola cosa preoccupa il Marx: trovare la legge dei fenomeni
che esso studia; e non solo la legge che li regge nella loro forma
determinata che è dato osservare durante il dato periodo di tempo. No,
ciò che lo interessa sopra ogni altra cosa è la legge delle loro
variazioni, del loro svolgimento, vale a dire la legge del loro
passaggio da una forma ad un'altra da un ordine di collegamento ad un
altro." E dopo averne confermato l'esattezza aggiunge: "spetta
all'investigazione di appropriarsi la materia in tutti i suoi
particolari, di analizzarne le varie forme di svolgimento, e di
scoprirne l'intimo vincolo. Finito tal compito, e solo allora, si può
esporre il movimento reale nel suo complesso." Movimento reale nel suo
complesso che viene senz'altro, poche righe più sotto, paragonato, per
contrapporle con le note motivazioni, al movimento reale nel suo
complesso concepito dal Hegel col suo metodo dialettico-idealistico.
Altro punto sarebbe quello di vedere se il Marx abbia usato con
altrettanta abilità nei due campi (quello economico-sociale e quello
storico-filosofico) e se il suo contributo nei due campi sia altrettanto
essenziale. Probabilmente potremmo concludere che il presupposto da cui
parte la sua rivoluzione antihegeliana (il materialismo), era bensì tale
da non intrarciarlo in una indagine di tipo sociologico-economico, e
anzi di favorirlo facendogli schivare la veramente semplicistica ed
ingenua applicazione del meccanismo triadico alla realtà naturale e
sociale che Hegel aveva compiuto. Ma era altresì tale da condurlo ad un
fatale equivoco nel campo dell'applicazione del metodo della negazione
nel campo della filosofia della storia. Quivi infatti la eliminazione
del momento spirituale come elemento dialettico autonomo, lo ha
costretto a postulare alla fine dello svolgimento speculativo non un
momento meramente formale (la spiritualità) ma una condizione sociale
particolare (la società senza classi), che per quanto generalizzata non
cessa di essere una condizione sociale particolare, che deve essere
lasciata al suo posto all'interno della storia e non esserne
extrapolata, per essere posta ad una distanza qualitativa degli altri
momenti storici.
Da ciò il carattere arcaico della filosofia della storia di Marx, in ciò
del tutto simile all'utopismo di un Rousseau. Il problema non era quello
di rifiutare la spiritualità, come il memento dialettio autonomo, ma
quello di privarla del carattere "religioso", cioè appunto astratto e
non dialettico, rispetto alla personalità dello studioso (dell'uomo in
definitiva), che non solo è caratteristico della tradizione teologica
prehegeliana, ma della filosofia hegeliana stessa.
A nostro avviso perciò in conclusione, i due tipi di procedimento
dialettico non solo esistono entrambi in Marx, ma in astratto, dati i
diversi campi a cui si applicano sono entrambi perfettamente
giustificati. In pratica poi chi volesse vedere in quale dei due campi
Marx abbia dato il migliore suo contributo, dovrebbe secondo noi
concludere che il suo presupposto materialistico gli permise di dare
molto migliori risultati nell'ambito della ricerca scientifico-economica
che non nell'ambito storico-filosofico, dove, non per mancanza di
dialetticità ma per vero e proprio pregiudizio antiidealistico mancò il
segno di un autentico superamento del "sistematismo" hegeliano.
(1) pag. 347 del citato numero della rivista di Filosofia.
(2) pag. 343 cit. riv. di Filosofia.
(3) pag. 354 lavoro citato.
(4) Al "Congresso della dialettica"
recentemente svoltosi a Milano, il Bobbio ha però precisato che per
dialettica, oggi deve intendersi "l'analisi dei linguaggi argomentativi
e persuasivi"
(5) pag. 354, Bobbio cit.
(6) traduzione italiana di Luigi Firpo in appendice al primo volume del Capitale ed.Utet (pag. 737/8) Dunque,
salvo che si voglia discutere la sistemazione dei momenti della logica
fatta da Hegel, il che non è fatto dal Bobbio, altrettanto giustificato
in astratto è l'uso dei due metodi in Marx, ed anzi verosimilmente
grande parte della sua grandezza e del suo fascino sono attribuibili
proprio alla sua capacità di destreggiarsi tanto agilmente con due
metodi così diversi in due campi del sapere così diversi essi stessi. Il
che appunto ha permesso ad Hengels ed ai suoi seguaci di parlare di un
sistema filosofico marxiano e del marxismo come di una visione del
mondo.